02.04.2022 – 07.20 – “Ci sono tutte, le indemoniate di Verzegnis. Antonia e Giulietta, dallo sguardo smarrito e inebetito; Rosetta, che ebbe il marito ucciso dalla sifilide; l’illibata Rosalba, della quale si diceva avesse a ogni plenilunio chiassoso commercio carnale con sette demoni alla volta; Claretta col marito sperduto per l’Europa e cinque figli cui badare; Margherita, bella e fresca come un frutto da cogliere, la cui verginità preservata era un dono troppo prezioso per lasciarlo avvizzire; Violetta, rosicata dalla smania della lettura dei romanzi e, da qualche tempo, da libelli sovversivi; e poi le altre, trenta e più, con Annamaria e Chiaretta silenziate in tutto quel tumulto da una consapevolezza nascosta, e dalla speranza di riavere all’ospedale la quiete perduta.” (pag. 105)
Il romanzo “Le indemoniate di Verzegnis” di Pietro Spirito è stato ristampato dalla casa editrice Biblioteca dell’Immagine dopo vent’anni dalla prima pubblicazione, avvenuta nel 2002 con la casa editrice Guanda. Ad oggi, la stampa originaria di quest’opera storico-allegorica è diventata un pezzo da collezione. Inutile sottolineare la già nota maestria di Pietro Spirito nel saper cogliere da fatti di cronaca una sottile e delicata forma narrativa che accompagna il lettore verso lidi di scoperta interiore. Giornalista e cronista del quotidiano Il Piccolo a Trieste e scrittore di romanzi, nel 2002, Pietro Spirito prese a cuore la storia di queste donne indemoniate a cavallo tra il 1878 e il 1879 a Verzegnis (Carnia) e cercò di scavare a fondo nel dubbio degli eventi puramente storici, sfruttando una narrazione di tipo espressionista a cui era legato nelle letture di Gadda, Basile e Consolo, per conferire all’opera una coerenza complessiva tra stile, contenuto e storicità. Ma fece di più: vide una possibile correlazione con il suo periodo storico di una politica del tempo divisa in disguidi e scaramucce tra governo e magistratura (2002) e l’evento demoniaco dell’Ottocento dove il contesto sociale, seppur differente, ripresentava le stesse dinamiche tipiche dell’esperienza umana. A pagarne le conseguenze è sempre il popolo. E come sottolinea più volte Spirito nell’introduzione alla ristampa, nella storia dell’umanità sono state sempre, o la maggior parte delle volte, le donne a rispondere più di altri, poiché considerate anelli deboli, delicate, impure e frastagliate, bersaglio più rapido, dunque, su cui riversare ogni forma di inadeguatezza, rinuncia e violenza.
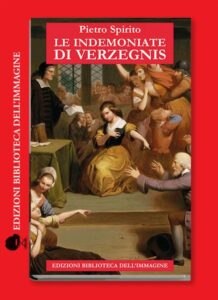 Le indemoniate di Verzegnis è un romanzo volutamente in forma di denuncia sociale. La scelta stilistica in chiave allegorica, verte l’attenzione principalmente sul tema del femminile quale elemento sottovalutato e poco salvaguardato, nonostante “le donne siano gli esseri più intelligenti e lungimiranti della nostra razza, perché si devono occupare della cura di ogni vita e affrontano la fatica con praticità e sensibilità allo stesso tempo, conservando il senso del cammino”, confessa Pietro Spirito. Ed è proprio l’elemento sottovalutato che lo scrittore ci tiene a ribaltare nell’ideologia comune, poiché la storia di queste donne è una storia di rivolta e protesta attiva, allo stesso modo che specifica Luciana Borsatti nel suo saggio “Le indemoniate. 1879: sfida tra stato, scienza e chiesa a Verzegnis” in ristampa in questo periodo dalla casa editrice Castelvecchi, da cui lo stesso Spirito ha tratto spunto nelle ricerche: “Le donne avrebbero lanciato al clero una sfida e un appello disperato, espressi nel linguaggio simbolico della possessione”.
Le indemoniate di Verzegnis è un romanzo volutamente in forma di denuncia sociale. La scelta stilistica in chiave allegorica, verte l’attenzione principalmente sul tema del femminile quale elemento sottovalutato e poco salvaguardato, nonostante “le donne siano gli esseri più intelligenti e lungimiranti della nostra razza, perché si devono occupare della cura di ogni vita e affrontano la fatica con praticità e sensibilità allo stesso tempo, conservando il senso del cammino”, confessa Pietro Spirito. Ed è proprio l’elemento sottovalutato che lo scrittore ci tiene a ribaltare nell’ideologia comune, poiché la storia di queste donne è una storia di rivolta e protesta attiva, allo stesso modo che specifica Luciana Borsatti nel suo saggio “Le indemoniate. 1879: sfida tra stato, scienza e chiesa a Verzegnis” in ristampa in questo periodo dalla casa editrice Castelvecchi, da cui lo stesso Spirito ha tratto spunto nelle ricerche: “Le donne avrebbero lanciato al clero una sfida e un appello disperato, espressi nel linguaggio simbolico della possessione”.
La scienza e la Chiesa avevano considerato l’evento sovrannaturale causato dalla debolezza tipica della femminilità su cui andavano, di conseguenza, effettuati gli esorcismi che Pietro Spirito non manca di descrivere con uno stile di sublime ironia inscindibile allo stesso tempo dalla tragicommedia del supplizio, nel tentativo di far emergere la stoltezza e l’insensatezza dei gesti tipici di un sistema patriarcale che nulla comprendeva della realtà femminile. Erano anni di povertà endemica, l’emigrazione degli uomini, il peso delle responsabilità familiari che si sommavano alla particolarità della posizione geografica del paese, la precaria condizione sanitaria insieme all’isolamento fisico e psicologico, ai capovolgimenti politici e amministrativi avvenuti dopo l’unità d’Italia e la guerra ideologica e culturale tra lo Stato liberale e la Chiesa cattolica. A tutto ciò si potrebbe aggiungere una probabile contaminazione delle farine a causa di un fungo tossico che provocava allucinazioni (ma di cui non si sa chi ne fosse a conoscenza in quel tempo) e l’ignoranza atavica basata sulla mancanza di strumenti culturali a disposizione verteva ogni credenza sulle leggende o sul passaparola generazionale. Le donne montanare, e non solo loro, erano per eccellenza le persone che si occupavano di sostenere l’intero sistema familiare e di conseguenza sociale, occupandosi della casa, del bestiame, dei campi, del cibo, dei figli e del marito, presente o assente, oltre a gestire tutta l’economia. La stanchezza e la possibilità di esprimerla non erano contemplate. E parallelamente, se lo Stato prevede dei tagli nel sistema, le prime ad essere toccate sono le donne.
In questo senso, la documentazione della storia, gli articoli di giornale dei tempi e le ricerche sanitarie fatte nel mentre e a seguire, non hanno tenuto conto della linfa umana che scorreva dentro queste femmine, non bestie, ma persone. Ed è proprio qui che arriva la letteratura a svelarsi come chiave dell’interpretazione del contemporaneo, partendo dal passato che mai si distanzia nella storia dell’uomo dal nostro presente. “E’ costumanza dei cronisti, e dei redattori dei fogli notiziari, non tanto ricercare il vero nella sua sostanza più esatta e certa (…) quanto piuttosto correre dietro alle più meravigliose epifanie, dare ascolto a chi fa la voce più alta d’altri, osservare con fuggevole interesse i disegni facili e immediati, dare conto dello sventolio dei drappi di maggior colore e forma. Così che la cronaca, il resoconto di quegli avvenimenti, si ferma là dove comincia il non detto, il taciuto, quel silenzio ignorato in cui spesso si affondano le radici prime dei fatti, dei quali i cronisti non danno che un resoconto d’apparenza, una racconciatura di parole, numeri e nomi sempre distanti dalla veridicità.” (pag. 41)
Il demone, dunque, è il male dell’omertà. La disattenzione dell’altro da sé, la smania del potere che genera conflitto e inevitabilmente coltiva terreno fertile per il malvagio che, a sua volta, si espande a macchia d’olio su tutto ciò che è vulnerabile e contaminabile. Un’opera di stile e scaltrezza, quella di Pietro Spirito, nel riconoscere una cifra moderna dentro una storia che sottolinea però un sistema sociale inalterato; un’opera di attenzione umana da parte di un occhio maschile che si confessa “quale convinto assertore della superiorità del femminile in tutte le sue forme” in un tempo ancora attuale nel dover affrontare la protesta di ogni forma di diseguaglianza.
Francesca Schillaci


