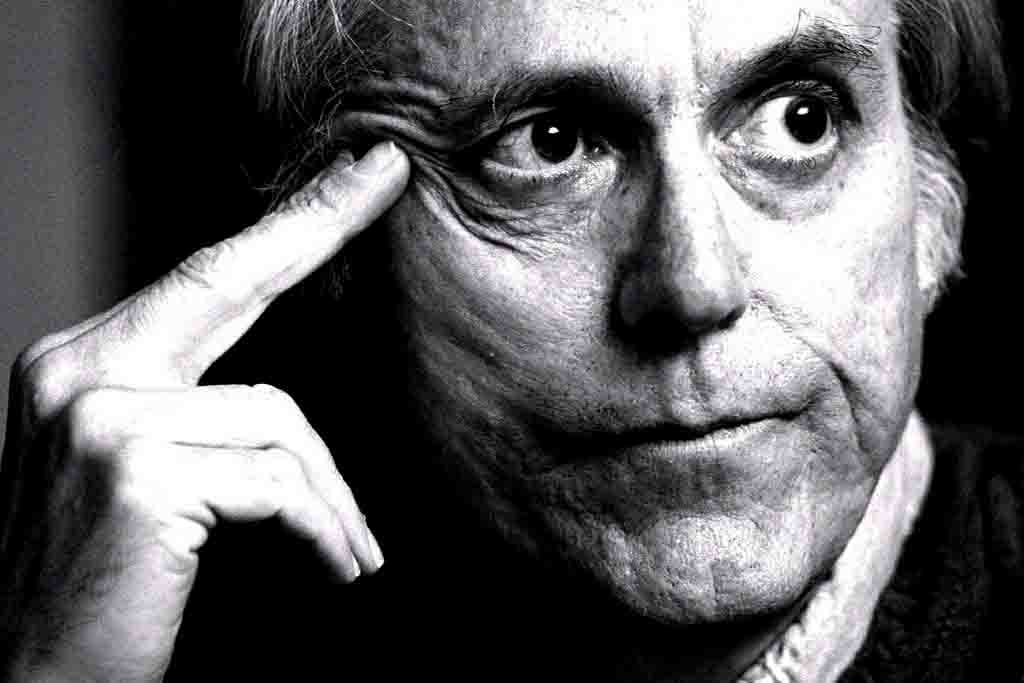23.03.2021 – 12.40 – “Nessuno vuole chiamarla Terza Guerra mondiale, ma è di questo che si tratta, – dice Martin” (p.69). È questo il reale tema de Il Silenzio di Don Delillo?
La risposta viene lasciata al lettore, mettendolo nella condizione di accettare lo stato d’inquietudine in cui viene fiondato dalla lettura per poter capire la domanda. In un’intervista rilasciata per il manifesto, Delillo confessa la difficoltà di portare a termine il lavoro de Il Silenzio, (Einaudi, traduzione di Federica Aceto, 2021) romanzo breve di sole cento pagine che però l’ha visto impegnato dalla fine del 2018 fino a marzo del 2020.
Conoscendo, dunque, il tempo di stesura del libro, nasce immediatamente spontanea una domanda, dopo aver letto Il Silenzio: Delillo è stato capace, inconsapevolmente, di intrappolare un presagio di quello che sarebbe accaduto nel tempo del 2020, con la pandemia Covid? In parte sì, poiché il cuore del romanzo si basa sull’arrivo improvviso di un’epidemia, un virus tecnologico che interrompe ogni forma di comunicazione virtuale provocando un black-out generale a Manhattan nel 2022. Al centro di questo frastuono, ci sono cinque personaggi: Tessa e Jim su un aereo di ritorno da Parigi e destinati ad arrivare a casa degli amici Max e Diana per guardare la finale di calcio. Nel tempo che divide gli amici sull’aereo dagli amici in salotto, avviene l’interruzione del rumore, con sbalzi dell’areo, scene in televisione interrotte dal rumore bianco e l’incapacità dei personaggi di comprendere la portata dell’evento. Solo Martin, figura centrale del libro su cui Delillo spende il massimo dello stile, si rivelerà essere inerme, distaccato e forse preparato all’avvento del grande silenzio.
L’autore mette in scena viva il movimento della nostra paura più grande, che non sappiamo però ammettere: se la tecnologia si arrestasse, che ne sarebbe di noi?
L’inquietudine e il senso di disagio che Delillo impone come sensazioni formicolanti negli occhi di chi legge, sono necessarie per metterci di fronte al fatto concreto della nostra imprevedibilità, la stessa che abbiamo creduto di estirpare con il controllo sempre più raffinato dei mezzi di comunicazione, il nostro ego smisurato su ogni forma vivente attraverso la misura e la materia, il calcolo preciso di ogni movimento terrestre, nostro e di ogni cosa.
Come reagiremmo a un obbligo tale, come quello del silenzio? Max inizia a fissare lo schermo bianco e a produrre lui stesso le voci dei commentatori della partita, mentre sull’aereo Jim continua, imperterrito, a leggere sullo schermo a voce alta le frequenze dell’altitudine, i tempi di atterraggio e la velocità misurata; Tessa continua ad annotare sul suo quaderno le frasi a frammento che le vengono in mente, rispondendo contemporaneamente alle domande continue di Jim. Diana, moglie di Max, si ritrova da sola in cucina con Martin a seguire i suoi flussi di coscienza sulla Teoria della relatività specialedi Einstein.
Ed è qui che si spolpa il cuore del romanzo: mentre “Diane si rese conto che non sapeva star seduta in silenzio in compagnia di Martin” p.29) e lascia spazio, invece, ad un lontano e profano desiderio di farsi amare dallo studente, Martin continua indifferente a porre domande: “Guardo lo specchio e non so chi è la persona che ho davanti, – diceva Martin. – La faccia che mi guarda sembra la mia. Ma in fondo perché dovrebbe? Lo specchio è davvero una superficie riflettente? E la faccia che vedo io è la stessa che vedono gli altri? Oppure è qualcosa o qualcuno di mia invenzione? Guardo quella faccia con interesse. Sono interessato, ma anche un po’ confuso. Capita mai anche agli altri? La faccia di ognuno di noi. Cos’è che vedono gli altri quando camminano per strada e si guardano a vicenda? La stessa cosa che vedo io? Tutte le nostre vite, tutto questo guardare. La gente che guarda. Ma cos’è che vede?” (p. 45)
La realtà, dunque, viene messa in discussione: Delillo mette in crisi, in modo estremo, la superficialità delle nostre vite e del nostro modo di viverle. Attraverso i suoi personaggi, ci rende narratori della nostra precarietà, consapevoli del fatto che la guerra esiste e può arrivare in qualunque momento a infrangere la nostra overdose di benessere, ma preferiamo pensare che “la guerra è un’altra cosa, la guerra succede altrove.” (p.26).
Ma che cos’è oggi la guerra, nel 2021? Sembra suggerirci questa domanda lo scrittore americano. Non è forse così che si fa una guerra, ormai? Nel rumoroso benessere dell’Occidente, cosa distruggerebbe le psicologie delle persone? Il silenzio.
I cinque amici, una volta riuniti nell’appartamento, iniziano a porsi delle domande, che impregneranno l’intera narrazione del romanzo. Nulla sarà più ovvio e scontato, ma nessuno dei cinque avrà il coraggio di avvicinarsi alla finestra per vedere cosa accade fuori, per verificare se quello che stanno vivendo esiste veramente o è solo una proiezione surreale delle loro menti.
Da dove arrivi questo virus, Delillo non lo dice e nessuno lo saprà. Quello che importa per l’autore è porre il dubbio come centro delle nostre coscienze, essere certi di non sapere tutto, abbandonare l’atavica megalomania della nostra permanenza e accettare, invece, la possibilità della perdita.
“Siamo forse un esperimento riuscito male, un piano messo in moto da forze che vanno al di là della nostra capacità di comprensione? Non è la prima volta che queste domande vengono poste. Gli scienziati si sono espressi a voce e per iscritto, fisici, filosofi. (…) Al secondo silenzio tutte le teste si girarono verso Martin”. (p. 77-78)
Il tormento, il dubbio, l’assenza di rumore e la paura portano inevitabilmente i personaggi del romanzo ad una sola possibilità: restare immobili. Solo in questo atto di accettazione e di stasi, Martin svela la riscossa del silenzio: “E’ tutta la vita che aspetto questo, e non lo sapevo.” (p.91)
f.s