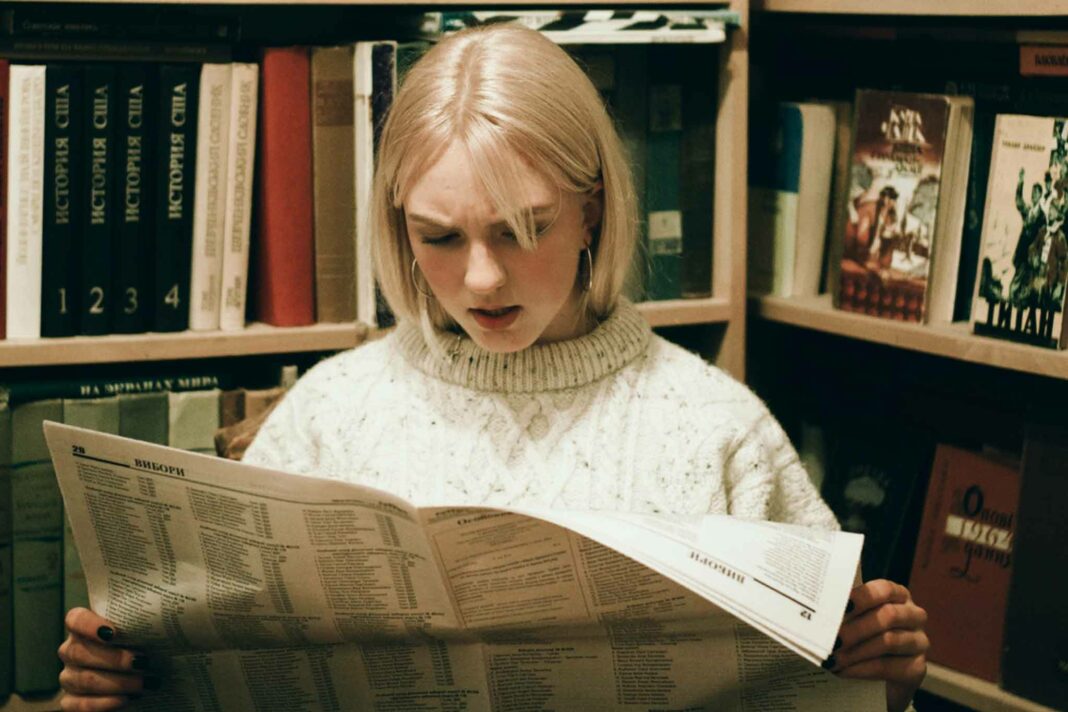06.02.2022 – 11.30 – Immagina di essere imputato penalmente per “frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato”. Patteggi la pena in otto mesi di reclusione e pensi così di avere dato un colpo di spugna al passato. Poi, la sera, ti rilassi davanti allo schermo del telefonino e digiti il tuo nome, così, per controllare. E il primo risultato a comparire ti fa ribaltare la camomilla: “Truffa Asl per fornitura di protesi” è la notizia giornalistica legata al tuo nome. E no, così non va. La tua immagine ne risulta danneggiata e la gente potrebbe farsi l’idea sbagliata che tu non sia una brava persona.
L’amministratore di una società coinvolto nella vicenda non esita ad agire giudizialmente per chiedere la rimozione dalla rete internet dell’articolo giornalistico. Egli sostiene che “La finalità di cronaca giornalistica si era…esaurita con la sentenza di patteggiamento, in mancanza di qualunque altro nuovo elemento che potesse valere ad attribuire attualità alla notizia.” Pertanto, “doveva riconoscersi il diritto all’oblio a tutela dell’immagine; diritto che poteva tradursi, oltre che nella contestualizzazione e aggiornamento della notizia di cronaca, anche, se del caso, nella relativa cancellazione, in difetto di un persistente interesse pubblico alla conoscenza.”
Insomma, viene invocato il “diritto all’oblio”, cioè il diritto a essere dimenticati. Non dai parenti o da chi ci vuole bene, ma dalla rete internet che tutto ricorda e che rivanga il nostro passato, conservando memoria e rendendo facilmente accessibili informazioni sul nostro contro che, magari, preferiremmo venissero dimenticate. Siamo stati coinvolti in una “frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato” e abbiamo patteggiato? È meglio che non si sappia. Certo, non è un segreto, ma è una notizia sul nostro conto che, on-line, si lega al nostro nome in modo innaturale invece di seguire il corso naturale delle informazioni, che il tempo allontana sempre di più facendole dimenticare.
Il “diritto all’oblio” ha degli elementi in comune con il “diritto alla riservatezza” (o “privacy”), ma sono due concetti che vanno tenuti ben distinti. Infatti, mentre il diritto alla riservatezza vieta la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima della persona e tenuti riservati, il diritto all’oblio ha come obiettivo impedire che notizie, già legittimamente pubblicate e, quindi, sottratte alla privacy, possano essere rievocate nel tempo anche quando non sono più attuali o rilevanti. Al venir meno dell’attualità della notizia e dell’utilità sociale della pubblicazione, si aggiunge il fatto che lo scorrere del tempo modifica la personalità dell’individuo. Pertanto, la ripubblicazione di una notizia già divulgata in un lontano passato può dare un’immagine della persona diversa da quella attuale, con il rischio di ledere e danneggiare l’identità personale e la reputazione del soggetto coinvolto. Il diritto all’oblio consiste, pertanto, “nel diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione, a distanza di tempo, di una notizia relativa a fatti commessi in passato o a vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti.”
A questo diritto si contrappone il “pubblico interesse” nell’attività di conservazione delle raccolte delle edizioni dei giornali pubblicate, tale da essere ripetutamente ricordato nella Costituzione italiana: quale strumento di ricerca storica (art. 33) e quale espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero (artt. 21 e 33). “L’archivio di cronaca giornalistica o, più propriamente, l’attività di raccolta ed archivio delle passate edizioni di un giornale accomuna – senza ricorso a criteri diretti a segnalare a maggiore o minore rilevanza storica dei fatti e quindi senza rielaborazione critica – tutti gli accadimenti; ad esso deve riconoscersi copertura costituzionale sia in quanto strumentalmente connesso all’attività di ricerca storica, quale perimetro di un possibile suo utilizzo, sia perché comunque espressione della generale manifestazione del pensiero”.
Dunque, coesistono due diritti e interessi contrapposti: quello personale dell’individuo, che invoca il diritto all’oblio, e quello generale di archivio della cronaca giornalistica. Non si tratta di stabilire chi prevalga, ma di trovare un equilibrio tra tutti gli elementi in gioco, che può essere individuato alla luce dei seguenti due principi:
– “Il diritto all’oblio è il diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione – a distanza di un importante intervallo temporale destinato ad integrare il diritto ed al cui decorso si accompagni una diversa identità della persona – o il mantenimento senza limiti temporali di una notizia relativa a fatti commessi in passato”;
– “In materia di diritto all’oblio là dove il suo titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi – appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza – e la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore”.
La “deindicizzazione” della notizia appare, quando è possibile, la soluzione ottimale e più equilibrata per risolvere il dilemma. (Cassazione n. 9147/20)
[g.c.a]